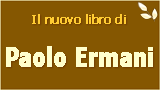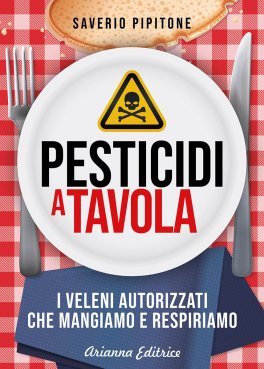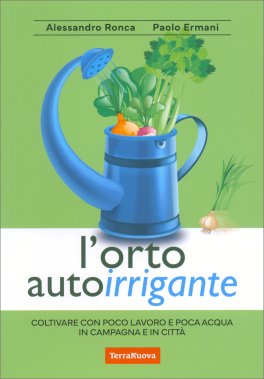L’umanità da secoli interagisce con l’ambiente naturale modificandolo per trarne dei vantaggi. Queste interazioni tra uomo e ambiente si sviluppano per motivazioni diverse. La necessità di ricavare spazio per costruire abitazioni, la ricerca di materie prime come legna, metalli, rocce, la volontà di creare dei collegamenti come strade, ponti e la costante necessità di nutrirsi, hanno prodotto un crescente impatto su numerosi ecosistemi naturali. La crescita della popolazione, unita al “progresso economico”, determina quotidianamente una perdita inversamente proporzionale di terre vergini, spazi naturali e, inevitabilmente, sta portando al collasso dell’intero
pianeta. Uno degli aspetti sui quali occorre soffermarsi maggiormente è proprio la produzione di cibo e di conseguenza il settore agricolo. Se guardiamo ai dati, l’agricoltura, e in particolare l’agroindustria, produce conseguenze enormi a livello ambientale. Una fetta importante delle emissioni di gas serra (tra il 30% e il 40%) sono prodotte dal settore agroalimentare. Enormi distese di cereali coprono intere pianure del mondo, gigantesche aree sono coltivate a soia e mais per sostenere gli allevamenti intensivi, (125 milioni di ettari di soia sono coltivati nel mondo e 350.000 ettari nel nostro paese), vaste aree fertili sono trasformate in serre e coltivazioni industriali, le quali portano a una perdita di suolo e di biodiversità. Macchinari sempre più grandi, complessi ed energivori sono costantemente all’opera per mantenere alta la produzione e soprattutto illimitati i guadagni (un trattore di potenza media consuma su strada circa 25 litri di gasolio ogni ora, che aumentano a pieno carico o durante lavorazioni agricole).
Tutto ciò ha prodotto una grave crisi ecologica e biologica. A causa dell’agricoltura industriale si è persa una grande quantità di terra fertile e di organismi viventi, di conseguenza assistiamo a una perdita di biodiversità. L’utilizzo di metodi industriali ha comportato la scomparsa di centinaia di varietà di frutta e verdura, che nei millenni erano state selezionate in modo naturale ed erano in grado di adattarsi a climi e suoli diversi, magari a scapito dell’aspetto estetico ma non certo della qualità.
Nella sola Italia sono centinaia le varietà di ciliegi, meli, susini, viti, pomodori, che non sono quasi più coltivati se non in piccole produzioni di nicchia e marginali e che rischiano di scomparire, (se guardiamo al nostro paese si sono perse 6000 varietà di frutta e verdura dal secolo scorso e delle 2000 che rimangono oltre la metà sono in declino).
Nel frattempo l’industria brevetta varietà incapaci di resistere agli stress idrici o climatici, ai suoli poco fertili. Si tratta di varietà tutte uguali che hanno come vantaggio la capacità di produrre tanto e nel minor tempo possibile e con aspetto e dimensioni invitanti. Poco importa se tali vegetali necessitino di maggiori quantità di nutrienti o di acqua, l’industria provvede. Poco importa se frutti e ortaggi si ammalano di più, l’industria provvede e guadagna un bel po’. Ecco dunque il nascere di colossi industriali che uniscono la produzione di semi e piante alla produzione di sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti.
Riguardo dunque alla complessità del sistema agroalimentare e all’impatto che questo produce sulla natura, questo articolo vuole mettere a fuoco uno degli aspetti più gravi e controversi, l’utilizzo dei pesticidi e le gravi conseguenze che producono su esseri viventi ed ecosistemi.
Quando parliamo di pesticidi, parliamo di numerose categorie di prodotti chimici come insetticidi, erbicidi, funghicidi ecc. Solo l’EPA ha valutato e monitorato 1.235 formulanti usati negli USA per produrre 16.810 pesticidi e tali pesticidi sono stati venduti in ben 46.147 prodotti diversi. Si tratta di numeri che fanno accapponare la pelle ma è niente se guardiamo ai chilogrammi consumati. Nel mondo vengono usati 2,3 miliardi di kg di pesticidi ogni anno, con alcuni paesi come Cina e USA in testa alle classifiche.
Anche sostanze pericolose, e in molti paesi bandite, sono ancora massicciamente prodotte e consumate. Il DDT ad esempio viene usato non poco (3,3 milioni di kg) pur essendo un potente veleno mutageno e persistente, illegale in Italia, negli USA e in molti paesi dagli anni ’70.
Come afferma Francisco Sanchez Bayo dell’Università di Sydney, “i pesticidi rilasciati nell’ambiente possono influenzare le specie bersaglio e non bersaglio in modo contrario alla loro destinazione d’uso”. “L’applicazione di insetticidi in agricoltura spesso si traduce in successivi focolai di parassiti a causa dell’eliminazione dei nemici naturali” Lo scienziato inoltre puntualizza come “ negli ecosistemi acquatici, insetticidi e funghicidi spesso inducono la fioritura di alghe, poiché le sostanze chimiche riducono il pascolo da parte dello zooplancton e degli erbivori bentonici”. Chiaramente tutti questi “effetti collaterali” sono impossibili da verificare in laboratorio, data la complessità degli ecosistemi e l’interazione tra i vari organismi che si verifica in natura. Si è per esempio visto che il persistere di insetticidi di sintesi nei tessuti delle piante e dei funghi diventa una trappola mortale, anche a distanza di tempo, per quegli insetti che si cibano di funghi, come la coccinella Psyllobora vigintimaculata che ha lo svantaggio di cibarsi di conidi e ife dell’oidio, il quale mantiene e trasmette il veleno nefasto usato sulla pianta dall’agricoltore. Altri studi invece mettono in luce la pericolosità degli erbicidi e la capacità di intervenire sulle catene alimentari. Si è infatti verificata una decrescita di piante del genere Asclepias, le quali sono uno dei principali nutrimenti del bruco della farfalla monarca, che infatti ha subito un crollo della popolazione dell’81% dal 1999 al 2010. Uno dei simboli del Midwest americano, la bella farfalla arancione che compie una delle più impressionanti migrazioni del mondo degli insetti, rischia un inesorabile declino a causa degli erbicidi chimici usati in agricoltura.
Se dunque è leggenda che il battito d’ali di una farfalla possa produrre un uragano dall’altra parte del globo, è una certezza che l’uragano ecologico ed economico può abbattersi su di noi anche prima del previsto, stando ai dati sulle api. Questo importante gruppo di insetti, che comprende circa 20.000 specie descritte nel mondo, è il più importante gruppo di insetti impollinatori a livello mondiale. Si tratta della “chiave riproduttiva” di centinaia di migliaia di specie vegetali selvatiche, cui va aggiunto un non meno sbalorditivo dato riguardo alla produzione agricola. Le api sono infatti responsabili dell’impollinazione dell’85% dei campi coltivati e della produzione agricola mondiale. Gli studi dimostrano un trend negativo a partire dagli anni ’90, trend che diventa sempre più drammatico con il passare del tempo ed il sommarsi degli effetti dei cambiamenti climatici. Dalle analisi indicate in un recente studio sul monitoraggio delle api di Zattara e Alzen, si ipotizzano due diversi scenari; nello scenario più ottimistico è stato rilevato che migliaia di specie di api sono diventate troppo rare per essere correttamente censite, mentre nello scenario pessimistico abbiamo tali specie estinte localmente o a livello globale. Come affermano i due ricercatori “in ogni caso il declino della biodiversità delle api () avrà effetti sull’impollinazione a livello dei raccolti di piante coltivate e selvatiche con conseguenze ecologiche ed economiche”.
Va inoltre sfatato il mito di isole coltivate con questi prodotti chimici di sintesi che possano mantenere intatti i territori naturali o limitrofi. Il trasporto di tali sostanze chimiche negli angoli più remoti del pianeta è testimoniato dalla presenza dei pesticidi sulle montagne disabitate, tra i ghiacciai dell’Artico, negli oceani e foreste.
A spostarli sono fenomeni atmosferici come il vento e le tempeste (225 000 kg sono depositati dalle precipitazioni solo negli USA), ma anche gli stessi organismi viventi, una volta contaminati, diventano a loro volta vettori; è il caso di uccelli migratori, semi, pollini o plancton trasportato dalle correnti marine. Per citare alcuni esempi di contaminazione indiretta, residui del potente DDT sono stati trovati nei pinguini di Adelia (Geisz et al. 2008), nei leoni marini delle Galapagos (Alava et al. 2011) e nelle aquile pescatrici americane (Stocksted 2007).
La banalizzazione floristica dovuta all’uso massiccio di erbicidi è poi un fatto acclarato, basta ricordare i campi di cereali di 50-60 anni fa, che si tinteggiavano dei colori di papaveri e fiordalisi, finocchi selvatici e margherite, e che ora si presentano come lande desolate dove decine di milioni di spighe tutte uguali presentano paesaggi “morti” ed artificiali. Va inoltre sottolineato come la moltitudine di prodotti chimici possa iniziare ad interagire tra sé in natura, creando effetti di accumulo e sinergia sui viventi di cui non si conoscono gli effetti. Così diminuiscono migliaia di specie, si perde la biodiversità, ovvero la trama della vita, la sua complessità ed al contempo la sua resilienza. Viviamo in un pianeta ormai febbricitante che è ammorbato con veleni che aumentano la febbre. La crisi ecologica seguirà di un passo quella alimentare. Solo fermando in modo pressocché immediato la produzione e la vendita dei pesticidi, solo rivedendo ritmi e modalità di produzione agricola potremo in futuro scongiurare il pericolo più temuto dall’uomo, la fame.
Solo rivedendo completamente il rapporto tra uomo, cibo ed ecosistemi, potremo ripristinare l’equilibrio oggi tanto a rischio e proseguire il nostro racconto sulla Terra.
Referenze scientifiche
1) FACTORS AFFECTING THE ABUNDANCE OF BUTTERFLIES IN FIELD BOUNDARIES IN SWAVESEY FENS, CAMBRIDGESHIRE, UK T. H. Sparks & T. Parish - Biological Conservation 73 (1995) 221-227
2) Milkweed loss in agricultural fields because of herbicide use: effect on the monarch butterfly population JOHN M. PLEASANTS,
KAREN S. OBERHAUSER – INSECT CONSERVATION AND DIVERSITY - VOL 6 – 2016
3) Indirect Effect of Pesticides on Insects and Other Arthropods Francisco Sánchez-Bayo – Toxics 2021 Aug; 9(8): 177.
4) Agri-environmental indicator - consumption of pesticides – eurostat - statistics explained
5) Worldwide occurrence records reflect a 2 global decline in bee species richness - Research gate 2019
6) From silent spring to silent night: Agrochemicals and the anthropocene Tyrone B. Hayes* and Martin Hansen*,† - Agrochemicals and the anthropocene. Elem Sci Anth 2017
7) FAOSTAT ANALYTICAL BRIEF 16 Pesticides use Global, regional and country trends 1990–2018
8) THE EFFECTS OF FIVE HERBTCIDES ON TIIE NUMBERS OF CERTAIN INVERTEBRATE ANIMALS IN GRASSI AND SOIL C. J. S. Fox - CANADIAN JOURN OF PLANT SCIENCE VOL 44 ANNO 1964